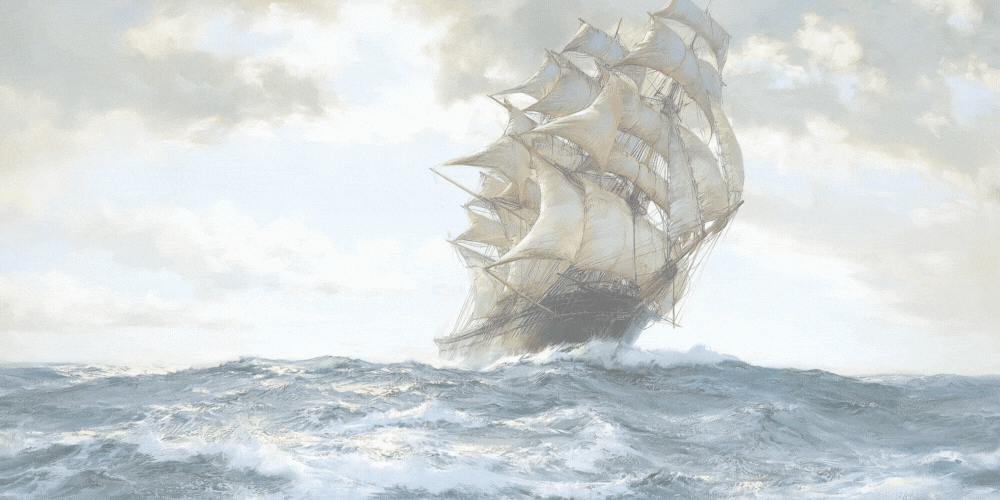
La Vergine e il Capitano
Quando io e mia madre siamo arrivati al porto, a bordo della vecchia 500 di mio zio, ho visto davanti a me una delle attrazioni più spettacolari mai realizzate dall’uomo. Una nave grande quanto la facciata del municipio, con ringhiere in acciaio e oblò che percorrevano rugose tutto il suo perimetro.
Pareva un sogno, lasciata lì a ballare sulle onde che entrano in porto, con la vernice blu a segnare i confini tra mare e ferro, e con il grande faro in cima a segnalarne il passaggio. Un mostro marino di leghe metalliche e braccia tatuate. Con decise pennellate bianche, stava riportato sulla fiancata il
nome della dama galleggiante: La Vergine.
Allora avevo solo diciassette anni. Mia madre diceva che ero troppo grande per starmene a casa a sentire la radio, così mi convinse a salpare. Mia madre è una donna forte. Vaghi e misteriosi diari di famiglia raccontano che durante il parto non urlò mai, neanche per un secondo. Era rimasta sul letto, ferma, con lo sguardo corrucciato rivolto verso il soffitto crepato dall’umidità e le gambe lasciate
aperte per darmi al mondo. Mi ricordo che, mentre salivo lungo la passerella, mi voltai e la guardai dritto negli occhi. Lei fece lo stesso, senza dire un “addio”, senza farmi un cenno con il capo per rassicurarmi. Senza un “stai andando lontano, figliolo: il trucco è non guardare l’orizzonte”.
Realizzando che quello era tutto ciò che avrei ottenuto dalla donna silenziosa, con gli occhi guardai oltre e vidi il mio riflesso nelle grandi vetrate dell’acciaieria della città. Sembravo un rospo, in sovrappeso e con la bocca lucida di saliva. Il mio vestito era largo, apparteneva a mio padre. Ci
nuotavo dentro a quelle maniche da gentiluomo e a quei calzoni da scolaretto cresciuto.
Le mie impressioni, troppo velocemente per un ragazzo di provincia, non si dimostrarono errate: dopo soli tre giorni di mare, la ciurma era così che aveva deciso di chiamarmi. Rospo. Il luogotenente mi aveva dato una brandina nell’angolo destro della stiva, insieme agli altri mozzi e manovali. Quell’angolo era il più puzzolente della nave perché un tempo era lì che tenevano i formaggi stagionati. La Vergine nacque come nave mercantile e il suo scopo era quello di consegnare oltreoceano i prodotti caseari della fattoria Mostarde e Caciotte. La cosa buffa è che la mostarda non è un prodotto caseario e che Mostarde e Caciotte neanche le faceva le caciotte. Ogni sei mesi la nave tornava in porto per un nuovo carico ed era nell’angolo destro della stiva che i
formaggi stagionati trovavano il loro posto. Jack Cheese, Colby, Brick, Stilton, Cheddar . Tutti formaggi che necessitano di luoghi umidi e legnosi per una stagionatura ottimale. Io occupavo il posto del formaggio stagionato e le cosa non mi seccava. Dopo circa due settimane di
navigazione, l’unico amico che mi ero riuscito a procurare era Bill, il gabbiano di vedetta. Seguiva la nave giorno e notte, sorvolando sulle nostre teste e aspettando che qualche anima buona gli lanciasse gli avanzi del pranzo. Bill mi voleva bene. Ogni volta che mi vedeva, iniziava a starnazzare, forse perché l’odore di Jack Cheese che emanavo lo stuzzicava. A me piace pensare che fosse un’amicizia reale e fedele, anche se dolorosa, perché guardarlo volare mi costringeva ad allungare l’occhio sul mare, verso l’orizzonte, e allora mi sentivo per un attimo vacillare, come se una sirena mi stesse tirando i piedi per trascinarmi negli abissi con sé. Un giorno di primavera vidi Bill posarsi sulla cresta di un mare particolarmente calmo per poi essere mangiato da un piccolo squalo. Capii all’istante che si era trattato di suicidio.
Passai i giorni seguenti cercando di trovarmi un amico con meno penne e con una parlantina più soddisfacente di quella di Bill, ma i manovali erano tutti omaccioni di più di venticinque anni, sempre
impegnati a lavorare per il loro superiore o a parlare dei loro calendari pornografici che nascondevano nella federa del cuscino. Un giorno, mi pare fosse marzo, mentre stavo pulendo il ponte, una mano possente mi strinse la spalla. Quando mi voltai, per poco non mi prese un colpo. Le callose dita del capitano mi stavano stringendo l’omero come se volessero staccarlo via dal resto del corpo. Io rimasi interdetto per qualche istante. Muto come un pesce per paura di essere gettato in mare e di fare la stessa fine del povero Bill. Il capitano usciva raramente dalla sua cabina. Era un uomo solo, anche se pare una cosa scontata da dire su un uomo anziano che ha passato tutta la sua vita in un oceano. Ma lui non sembrava semplicemente senza compagnia. Era solo nel senso più pieno del termine, o almeno questo è quello che ha percepito un ragazzino paffuto di diciassette anni. Una lunga barba gli scendeva dal viso grinzoso. Dire quanti anni avesse era un’impresa.
Avrebbe potuto averne cinquanta come duecento. Alto e possente, un tempo doveva essere affascinante e pieno di ammiratrici. Ora la navigazione l’aveva maciullato, spolpato come un cane con le ossa dell’agnello arrosto. Il fattore che lo rendeva il bucaniere più terrificante dei sette mari era la sua cecità. La creatura aveva perso l’uso della vista dieci anni or sono a causa del glaucoma. Il fatto che egli non fosse cieco dalla nascita lo si capiva dalle rugose fessure che aveva al posto degli occhi, ormai nascosti dalla pelle cadente e dalle sopracciglia folte. Da quelle fessure gli esseri
umani potevano scorgere se stessi e compatire la propria esistenza. Due fessure che, come due pezzi di vetro, rendevano opaca la vita e accecante la morte. Le cicatrici di un uomo che ha conosciuto la bellezza per poi vedersela portare via, come i venti trascinano altrove le nuvole. Quando li guardai per la prima volta, un moto di nausea mi sconquassò lo stomaco, facendomi sentire in fondo alla gola l’amarezza del passato e il sapore del pesce.
Il capitano mi spronò ad aiutarlo a raggiungere la sua stanza e udii la sua voce. In confronto a tutto il resto, pareva avere la voce più comune del mondo. Grezza e con un accenno di zeppola. La voce che si immagina appartenere a Babbo Natale o ad un avo sepolto da tempo. Una voce tra tante, che scalfisce l’anima come le più grandi banalità. Senza dire molto, feci da bastone al capitano che, nonostante non ci vedesse, mi guidò giù per le scale arrugginite del ponte. Nella sua camera mi offrì del rum da quattro soldi e io gli dissi che non avevo l’età per bere. Lui aggiunse che, se era per questo, non avevo neanche l’età per attraversare l’oceano. “Perché hai deciso di fare il marinaio?” mi chiese. Io rimasi in silenzio per svariati secondi e lui accennò ad una mia somiglianza con i merluzzi che pescava nel mare del Nord tanto tempo prima. Provai ad immaginare quell’uomo quando aveva la mia età e non ci riuscii. Persone come quelle hanno addosso una specie di eternità, sotto la pelle e sopra i vestiti. Non si riesce a collocarli in un tempo ben preciso, come non ci si spiega perché in una stiva di una nave, nonostante i lunghi anni di navigazione, si senta ancora un tanfo acceso di formaggio. Non si capiscono quelle rughe e non ci si spiega come facciano ad essere così tante, così come è impossibile contare le onde del mare. Sovvenni da quei pensieri e gli dissi che facevo il marinaio per spendere il tempo. Le ore a casa mia parevano trattenute da una corda che impediva loro di scorrere. In alto mare il tempo è qualcosa che non esiste, nominato a sproposito da chiunque, come il nome di Dio. Lui parve apprezzare queste mie pillole di filosofia spicciola, ma, dopo che ebbe serrato le labbra baffute, capii che avevo ucciso ogni sua voglia di fare conversazione. Infatti non rispose, non emise un fiato. Mi lasciò andare con un cenno del capo. Sorprendentemente, lo fece in direzione della porta, come se sapesse con esattezza dove e con chi si trovasse. Io iniziai a camminare e con la coda dell’occhio mi accorsi che la bottiglia di rum era stata aperta e che ora la sua bocca di vetro scuro poggiava su quella dell’uomo. Quando uscii dalla cabina del capitano mi sentii invecchiato, come un vino in una cantina dimenticata e sepolta dalla polvere. Mi guardai intorno e vidi solo acqua salata. Poi cadde la notte.
Sei mesi dopo eravamo giunti a destinazione. Quando scesi dalla passerella e misi piede sul cemento del porto straniero, mi venne un giramento di testa e caddi a terra, assaggiando, dopo secoli passati tra le onde, il sapore del nuovo. Avevo diciassette anni quando sono salito sulla Vergine e, fino al mio sbarco, avevo provato a contare quante volte la nave oscillava sotto i miei piedi. Un’oscillazione, due oscillazioni, tre, quattro… Poi, sistematicamente, come lo erano le oscillazioni, perdevo il conto e ricominciavo. Quei mesi di monotonia, passati a contare e a pulire i ponti della Vergine, erano caduti dal cielo come le gocce di pioggia: identici, incessanti e, appena inizi a credere che non ti ci abituerai mai, ti ci abitui e quel cadenzato scorrere delle ore diventa il tuo migliore amico. Su quel cemento nuovo ci sono rimasto tutta la vita. Quando dissi al capitano che
non sarei salpato di nuovo con la ciurma, lui non mi rispose di nuovo. Si girò, facendo ruotare il pesante cappotto blu, e tornò a bordo della sua Vergine. La nave salpò un paio d’ore dopo, con un nuovo carico da trasportare e dei calendari nuovi da nascondere. Dove la mia avventura da bucaniere era finita, presi moglie e casa. Trovai lavoro in un caseificio locale, forse per nostalgia
della mia branda nell’angolo a destra. Non vidi mai più il capitano e non ebbi mai l’occasione di scoprire il suo vero nome, come lui, sentendomi chiamare Rospo, non conoscerà mai il mio. Tutti i
giorni compravo un giornale e andavo al porto per scoprire se attraccata c’era la sua nave. In tutta la mia vita la Vergine non venne a farmi visita neanche una volta e questo mi ha procurato un perenne senso di nostalgia. Con il senno di poi, capii che forse non vederla più era stato un bene e mi limitai a pensare al capitano come ad un personaggio immaginario, vacuo, a cui si pensa solo quando si è soli e un po’ giù di corda; padrone dei sogni che si fanno dopo una bevuta di rum.

Il racconto La Vergine e il capitano, scritto da Martina Borgioni, nel 2021 è stato selezionato dalla giuria della XIV edizione del concorso Premio Nazionale Alberoandronico, piazzandosi al settimo posto su 801 opere con provenienza internazionale.